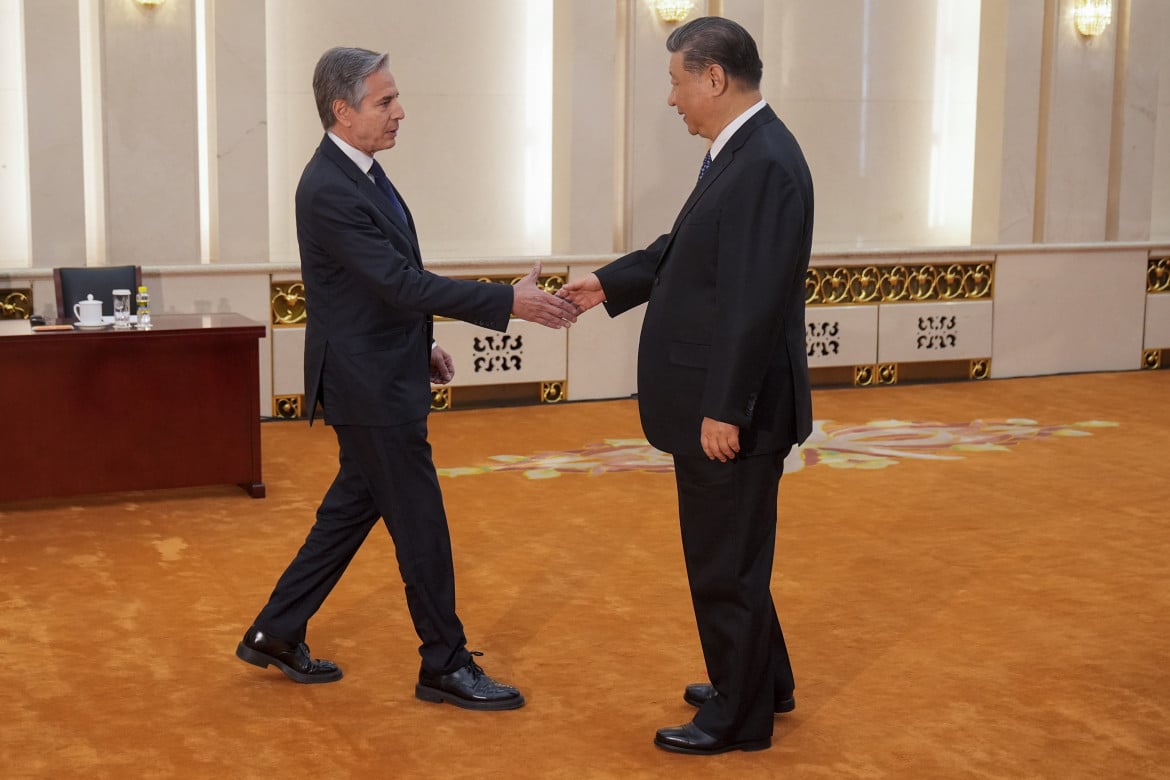Ci sono persone famose per essere diventate famose, ce ne sono altre che lo sono per non esserlo mai diventate. John Edward Williams è uno di loro. Il National Book Award ricevuto nel 1973 per Augustus fu l’unico riconoscimento che ebbe in vita, e lo dovette dividere con Chimera del postmoderno John Barth, campione di una corrente letteraria che Williams detestava. Per via dell’età, del fumo e dell’alcol non riuscì a terminare il quinto romanzo, Il sonno della ragione. O forse il motivo era un altro: in quelle pagine erano presenti spunti autobiografici sui quali Williams voleva mantenere il silenzio, non sapendo e non volendo trasferirli in scrittura.
Il suo ideale era una prosa tersa, essenziale ma non ellittica, classica ma non aulica, né sperimentale né confessionale. Sopportava Joyce e Woolf, che a suo parere erano più poeti che romanzieri, ma guardava a Flaubert. E nel suo insegnamento all’Università di Denver, dove diresse il programma di scrittura creativa fino al 1985, cercò di erigere un bastione di opere intoccabili contro gli scatenati controvalori del presente. Credeva di essere un conservatore del passato; non sapeva di essere un conservatore del futuro.
Nel 2005 la «New York Review Books» ripubblicò il suo terzo romanzo, Stoner, che quando era uscito nel 1965 aveva raccolto molte recensioni negative e pochi elogi. Era un romanzo fuori tempo, o non si sapeva quale tempo assegnargli. Perché l’edizione NYRB decollasse ci vollero una recensione di Morris Dickstein sul «New York Times» e l’insperato aiuto di Anna Gavalda, che lo tradusse in francese come puro labor of love. Nel 2011, all’uscita della traduzione, il mondo scoprì che in America c’era stato uno scrittore capace di innestarsi su un grade filone della narrativa europea: il romanzo di formazione dell’inetto, di colui che riesce, con grande fatica, a uscire dalle strettoie della sua umile nascita e della sua classe emarginata, ma non potrà mai competere con chi ha dalla sua la sprezzatura del bourgeois. In America, dove i ricchi sono diversi solo perché hanno più soldi, come disse una volta Mary Colum a Hemingway, il personaggio del romanzo di formazione deve essere almeno un Jay Gatsby, non il povero professor William Stoner, che nasce contadino, sposa una donna benestante che presto lo ignora, e per tutta la vita viene vessato dai colleghi. Non è un caso se il successo di Stoner nasce in Europa.
Il Meridiano delle Opere di John Williams appena pubblicato, con un’introduzione di Francesco Pacifico, due precise ricostruzioni a opera di Charles J. Shields e l’ottima cura di Francesca Pinchera (pp. 1560, € 80,00) è il monumento europeo a questo scrittore assolutamente americano, pur se fuori dal coro. Basta confrontare questa edizione con quella della American Library, che comprende solo i tre romanzi maggiori, Butcher’s Crossing, Stoner e Augustus. Il Meridiano aggiunge il primo romanzo, Nulla, solo la notte (1948), considerato un’opera giovanile anche dal suo autore; le due raccolte di poesie del 1949 e del 1965 (che, va detto, non fanno di Williams un grande poeta), i due frammenti dell’incompiuto Sonno della ragione e quattro racconti inediti anche in inglese, recuperati dallo stesso Shields, tra i quali spicca Uno di famiglia per la sua brutalità faulkneriana. Mancano i pochi saggi accademici, ma sarebbero comunque di interesse limitato.
Leggere Nulla, soltanto la notte è istruttivo, se non altro per misurare come Williams riesca a liberarsi dalle goffaggini stilistiche degli esordi.
Ha avuto bisogno di dodici anni, dal 1948 al 1960, per scuotersi di dosso tutti gli impacci del giovane scrittore che non sa ancora come far muovere un personaggio (nelle prime trenta pagine il protagonista Arthur Maxley non fa altro che trasalire, sogghignare, rabbrividire, stringere i pugni e fare balzi su dalla sedia; non c’è cliché di letteratura dozzinale che venga risparmiato al lettore) per arrivare al western flaubertiano di Butcher’s Crossing, dove la narrazione della caccia al bisonte e del successivo scuoiamento rivaleggia (in meglio) con le descrizioni della pesca alla lenza nelle Storie di Nick Adams di Hemingway, e la vicenda del giovane studente di Harvard fresco di lettura della filosofia trascendentalista e giunto nel West in cerca del sublime americano è raccontata con una fantastica alchimia di partecipazione e implacabilità.
Nella sua introduzione, Francesco Pacifico si chiede se Stoner sia un’opera del 1965 o del 2006, l’anno in cui si è cominciato a considerarlo «il romanzo perfetto». Non è importante affermare o negare che lo sia.
Ma se fosse un romanzo del 2024 sapremmo di sicuro dove l’accademia americana andrebbe a puntare il dito accusatore: perché Williams non dice chiaramente che l’odio di Edith nei confronti del marito è dovuto allo scaricare su di lui il risentimento nei confronti del padre che prima (forse) l’ha molestata e poi l’ha costretta a sposare il primo venuto?
Perché non ci viene fatto capire che se il collega Lomax fa di tutto per rovinare la vita di Stoner è perché lui si è reso colpevole di discriminazione nel bocciare Walker, il suo studente mediocre ma claudicante, soprattutto sapendo che anche Lomax è claudicante, e per giunta ha pure una gobba? (Tra l’altro, fu proprio questo incidente, non autobiografico ma preso dal vero, che ispirò il romanzo.)
E come si può tollerare che Stoner trovi un unico, breve momento di serenità nella relazione con Katherine, che deve presto abbandonare perché, orrore, è una sua studentessa?
Non importa, Stoner è la storia di un giusto, uno di quei giusti che reggono il mondo. Se la terra non è ancora deflagrata è perché milioni di Stoner si recano al loro lavoro tutte le mattine, sapendo cosa li attende durante la giornata e soprattutto quando tornano a casa la sera.
Ma il vertice dell’opera di Williams non è Stoner, è Augustus. In questo romanzo non-storico su un’immaginaria vita dell’imperatore, ricostruita attraverso lettere finte, documenti indiretti e una confessione finale in prima persona, Williams raggiunge la classicità che aveva sempre cercato.
Ha imparato a maneggiare l’ironia sovrastorica, che nei romanzi precedenti era presente ma non detta. Cesare non avrebbe mai scritto la lettera ad Azia che apre il romanzo, ma grazie a quella lettera possiamo immaginarci un Cesare che non parla come Cesare e nemmeno come il Cesare di Shakespeare. Augusto non avrebbe mai confessato di sentirsi a suo modo un inetto, come nella lettera che manda a Nicola di Damasco, ma solo a quel punto comprendiamo in che modo i quattro romanzi, che sembrano scritti da quattro persone diverse, sappiano trovare la loro unità.
Anche Augusto, l’uomo più onorato di ogni tempo, ha dovuto imparare, sbagliare, pentirsi e far finta di non essersi pentito. Non sa se poteva fare di più. Non sa nemmeno se davvero ha lasciato un mondo migliore di come l’aveva trovato. Sa solo che gli uomini andranno avanti, nel loro immenso futuro, nella confusione del loro cammino, e che nient’altro ha importanza.