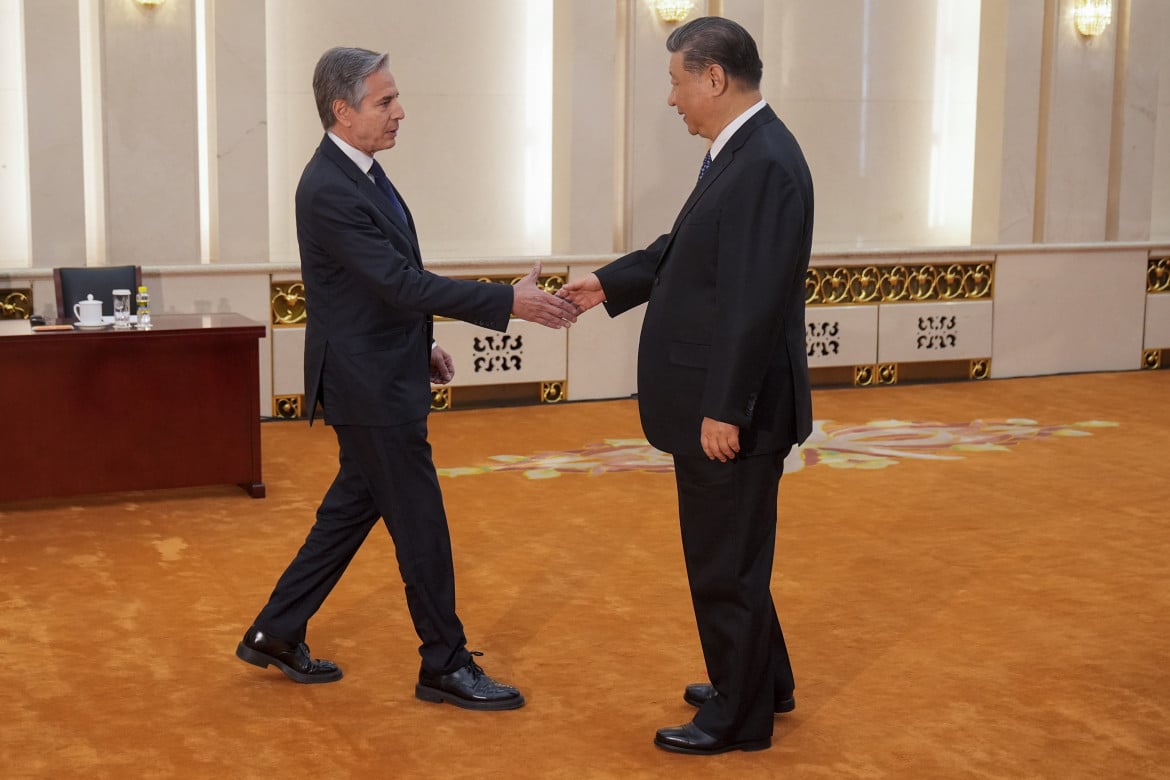Robert Ryman, spazio concreto, realista del come
L’arte di Robert Ryman (Nashville, 1930 – New York, 2019) è un’arte esigente. Arrivato a un certo punto della sua carriera, egli comincia a rifiutare proposte di esposizioni collettive sostenendo che «la maggioranza delle persone non comprende il mio lavoro, e questa difficoltà sarebbe ancora peggiore se le mie opere fossero affiancate da quelle di un altro artista». Nonostante ciò il suo lavoro è sovente associato a quello delle cosiddette Conceptual e Minimal Art.
In effetti la sua partecipazione, nel 1969, alle due esposizioni capitali dei suddetti movimenti artistici – When Attitudes Become Form (al Kunsthalle di Berna e all’Institute of Contemporary Arts di Londra) e Anti-Illusions: Procedures / Materials (al Whitney Museum of American Art di New York) – ha appiccicato un’etichetta durevole sul suo lavoro. E anche se Ryman guarda con rispetto al Minimalismo, sviluppa nel tempo un suo vocabolario personalissimo, e arriva, durante una conferenza nel 1989, a un’icastica definizione della propria opera qualificandola come «realista concreta».
Alla fine degli anni settanta, ritornando sui suoi primi passi pittorici, Ryman dice: «Volevo soprattutto capire come funzionavano le cose. (…) Capire cosa fa la pittura, come funzionano i pennelli, cosa succede quando metti tutto insieme, come reagiscono i colori tra loro e la composizione». È dunque il «come» a interessare l’artista, più che il «cosa»; e questo «come dipingere», più che «cosa dipingere», implica una priorità concessa al metodo, alla ricerca sui materiali, più che alla rappresentazione.
Questo è un altro motivo per cui Ryman tiene a precisare la natura non astratta del proprio lavoro, in quanto la cosa importante per lui risiede nei materiali, nei fatti, nelle esperienze, nei processi di creazione. E nel 1993 afferma: «Poiché nel realismo la questione di cosa si dipinge non è rilevante, l’osservatore è libero di vivere direttamente il dipinto».
Ryman non ha un percorso artistico convenzionale. Approdato a New York nel 1953 per seguire la passione jazzistica, si guadagna da vivere facendo il custode al MoMa, dove diviene collega di Dan Flavin, Sol LeWitt e Michael Venezia, impegnati nei servizi di sicurezza, educativi e bibliotecari del museo. La sua formazione pittorica avviene proprio osservando le opere della collezione, dove scopre l’arte moderna europea (Monet, Cézanne, Matisse) e l’arte contemporanea americana (Pollock, Rothko – che conosce personalmente nel 1957 – , ai quali si sente particolarmente affine, riconoscendo nelle loro rispettive arti qualcosa di «romantico»: «intendo dire che Rothko non è un matematico, la sua opera ha molto a che fare con i sentimenti, con la sensibilità»).
Poco incline all’imitazione, Ryman assorbe comunque, e traduce nel proprio linguaggio pittorico, ciò che osserva. Così, macchie e striature possono ricordare i gesti dell’espressionismo astratto, o le influenze di calligrafie orientali à la Kline. Numerosi disegni di questo periodo presentano intrecci verticali dall’apetto scritturale, una sorta di segni linguistici privi di contenuto semantico. E inoltre un certo modo di giustapporre e sovrapporre i piani, e di organizzare spessi segni di pittura su tela, possono far pensare a Burri e Soulages, sicuramente visti nel 1955, sempre nell’istituto newyorkese.
Dunque Ryman comincia a dipingere nel 1953, pochi mesi dopo aver ottenuto il lavoro di custode: «C’era un piccolo negozio di articoli d’arte all’angolo. Ho comprato due scatole di tela, un po’ di pittura a olio (…) e qualche pennello, pensando di provarlo e vedere cosa succedeva». E cosa è successo, poi, ce lo racconta oggi, fino all’1 luglio, l’esposizione al Musée de l’Orangerie: Robert Ryman. Le regarde en acte (la mostra è curata da Claire Bernardi, in collaborazione con Guillaume Fabius; il catalogo è in co-edizione Musées d’Orsay et de l’Orangerie e Actes Sud, pp. 136, 80 illustrazioni, euro 40,00).

Le opere sono installate seguendo le più scrupolose indicazioni dell’artista (ricordiamo qui che, nel 1987, Ryman fonda la Greenwich Collection, un’organizzazione senza scopo di lucro che supervisiona il progetto del catalogo ragionato e, più in generale, garantisce il mantenimento e la promozione della sua eredità artistica). Incessantemente interrogatosi sulle specificità dei propri mezzi espressivi, Ryman ritiene che le indicazioni offerte per presentare le proprie opere in sua assenza non siano solo mere indicazioni materiali, ma esplicitino anche l’intenzione estetica dell’artista, al fine di «completare» l’oggetto in fase di allestimento. «Parlando di completamento, non sto parlando di appropriazione – spiega Ryman –. Sto parlando di presentare il dipinto al mondo in un modo che ne renda chiara l’estetica. Il modo in cui ciò avviene è di grande importanza (…) Per essere finito, un dipinto deve essere visto correttamente».
Quindi il presupposto fondamentale per l’arte di Ryman è la sua iscrizione in uno spazio fisico. Non solo l’opera non può esistere senza essere vista, ma, ancor più, la sua percezione dipende dal suo ambiente. Il dialogo del supporto dipinto con lo spazio esistente assume nel corso degli anni una sempre maggiore importanza nella sua pratica. Come bene dice Claire Bernardi in catalogo, se i suoi primi dipinti si concentrano più sui rapporti compositivi interni alla tela, come negli Untitled degli anni cinquanta, la relazione dell’opera con la parete diviene chiaramente essenziale alla fine degli anni sessanta, come per Adelphi (1967), grande olio su tela, teso con nastri adesivi cerati direttamente sulla superficie del muro.
Questa dimensione di opera aperta nello spazio ha subito poi ulteriori sviluppi nel decennio successivo, quando Ryman è più specificatamente interessato alle modalità di installazione delle sue opere, come in Arrow (1976), piccolo quadro a olio su plexiglas, bullonato a parete con quattro fascette, sempre in plexiglas, due sul lato superiore e due sul lato inferiore. E, dando alle sue superfici una prospettiva più scultorea negli anni ottanta, ponendole volentieri anche in orizzontale, come in Pace (1984), dove l’occhio è attratto dallo spessore in legno in contrasto con la vernice bianca lucida del lato superiore, Ryman spinge ulteriormente le nozioni tradizionali della pittura fino a dispiegarla nello spazio tridimensionale, come accade in Journal (1988), un grande acrilico su pannello convesso fissato a parete con ganci d’acciaio.
Non è possibile ridurre l’opera di Ryman a un’unica, granitica idea. Essa si dispiega, attraverso l’azione pittorica, con una grande scelta di formati, supporti, intuizioni che variano a ogni nuova esperienza installativa. Ai materiali utilizzati l’artista accorda una grande importanza, al punto da servirsene anche per dare il titolo alle sue opere, come per la serie Winsor (1965-’66), che viene dalla nota marca di colori Winsor&Newton, e Classico, dal nome della carta usata. Pur eterogenea, questa di Ryman è un’opera che, complessivamente intesa, è di una tale acutezza, da valere la metafora forgiata da Arthur Danto che, su di una sua esposizione parigina del 1991, così scriveva: «L’esperienza offerta da questa mostra era dello stesso genere di quelle offerte dalle grandi conversazioni filosofiche». Dunque non di un’opera sterilmente formale si tratta, né tantomeno illusionistica; ma di uno spazio concreto che, dal brulicante silenzio delle sue superfici bianche, apre un varco sensibile alla riflessione.